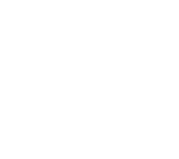Alcune riflessioni sulla mia modalità di impostare la prima seduta psicotrapeutica, concetti e atteggiamenti che aiutano, processi di pensiero che intralciano.
Mi è utile pensare che quando incontro qualcuno durante la prima seduta, mi sto trovando a interagire con una diversa cultura, come se avessi a che fare con qualcuno sulla cui coerenza con le mie idee, cognizioni e linguaggio non posso fare affidamento.
1 – Linguaggio:
Tanto per cominciare, non posso dare per scontato che parole che per me hanno un certo significato, attivino la stessa rete di associazioni nella mente del paziente. Mi trovo anche, e sorprendentemente, a mettermi in discussione anche quando penso di avere capito, al costo di risultare “ingenuo” agli occhi del paziente, al quale sto chiedendo di che sensazioni parla, quando riferisce di sentire “ansia”. Mi sono trovato a dover usare una tale cautela dopo aver constatato che, sebbene inizialmente il processo di “indagine” richieda tempo, l’investimento iniziale viene ripagato da risultati molto più veloci nelle sedute successive. Ecco alcuni esempi di questo processo.
Una giovane paziente si presenta in seduta lamentando degli “attacchi di panico” che si verificherebbero in casa, nella sua stanza, attacchi assolutamente assenti in altre situazioni. Nel corso del colloquio, emerge che questi “attacchi di panico” consistevano in pianti disperati dopo le frequenti litigate che la ragazza aveva con la madre, a cui era legata in una relazione altamente ambivalente, caratterizzata da frequenti escalation simmetriche.
Una paziente si presenta ad un incontro di follow-up lamentando un improvviso problema depressivo, a suo dire cominciato una decina di giorni prima. Mentre ne parliamo, apprendo che la madre, cui la paziente era molto legata, è mancata da poco.
2 – Assunzioni sul mondo:
Naturalmente, assieme al linguaggio non posso dare per scontato che la persona che ho davanti condivida le stesse mie idee sul mondo che ci circonda, sulle persone, sulle relazioni. Devo anzi assumere che esse siano fondamentalmente diverse; questo, infatti, mi permette di mantenere una “mente aperta” rispetto a ciò che mi dirà, al modo in cui le sue idee sono legate alle sue azioni, al modo in cui le sue azioni e le sue idee sono legate alla sofferenza che prova.
Un piccolo esempio: è mia abitudine pensare che quando faccio qualcosa di ‘buono’ o ‘generoso’ a vantaggio di qualcun altro, lo faccio prima di tutto per me stesso: semplicemente, è il mio modo di stare al mondo, e non mi sentirei bene altrimenti. Non mi aspetto di conseguenza nulla in cambio. Altri, invece, sono convinti che, siccome si comportano onestamente, rispettosamente oppure educatamente, le persone che incontrano sulla loro strada siano tenute a fare altrettanto; spesso chi parte da questo presupposto nutre una forte rabbia verso gli altri oppure verso sè stesso, segretamente rammaricandosi di non essere altrettanto ‘furbo’ o scaltro.
3 – Responsabilità del discorso: Al contrario di alcuni miei colleghi, non condivido l’approccio di chi pensa poter arrivare a formulare una “diagnosi della persona o del problema” prima di condurre l’intervento. Mi sento invece molto vicino alle idee tipiche della seconda cibernetica e del costruttivismo, in base alle quali ogni tentativo di osservare un fenomeno implica un’interazione con i fenomeno stesso. Tale interazione ha alte probabilità di produrre un effetto, e di conseguenza ogni osservazione o descrizione di fenomeno finirà molto probabilmente per modificare il fenomeno che pretene di descrivere. Seguite il mio ragionamento: se un discorso su qualcosa modifica quel qualcosa di cui parla, il primo colloquio include in sè i semi di ciò che potrà o non potrà essere cambiato. Questo implica la responsabilità, posta sulle spalle dello psicoterapeuta, di costruire (tramite il discorso) un problema che possa essere risolto.
Voglio riportarvi uno stralcio di un colloquio di Steve de Shazer con una adolescente di 16 anni; il terapeuta lavora per costruire una realtà basata sulle risorse della paziente, anzichè sulle sue mancanze.
T – “Allora, dove vai a scuola?”
P – “West High.
T – Ci vai davvero, oppure solo in teoria?
P – Solo in teoria.
T – Solo in teoria. Quanto spesso ci vai?
P – Due volte alla settimana.
T – Stai tutto il giorno quando ci vai?
P – A volte.
T – Come mai?
P – Ho molte cose da fare.
T – No, no; come mai quando ci vai rimani tutto il giorno?
Sono sempre colpito quando rileggo questo stralcio di colloquio: mi sembra un esempio così limpido di come si possa, implicitamente e senza dare nell’occhio, valorizzare le risorse di un/una paziente! Un esempio anche di come è possibile costruire un mondo diverso durante il colloquio, o come direbbe Giorgio Nardone “una realtà inventata che produce effetti concreti”…
Articoli Recenti
Giacomo Crivellaro; Psicoterapia Breve Strategica e Ipnosi a Firenze, Parma e Montevarchi (Valdarno)